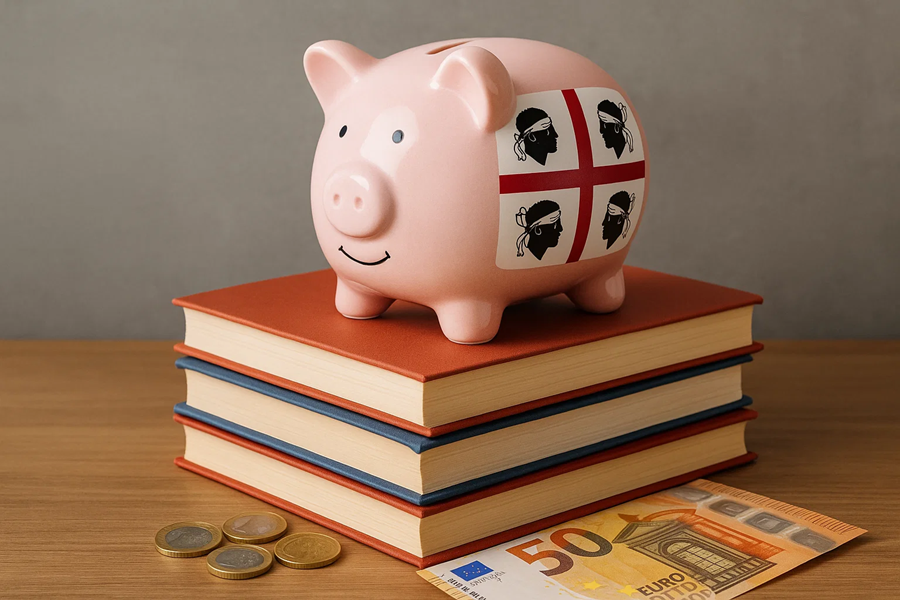di Tarcisio Agus
________________________
La notizia dell’avvio dei restauri di una parte residua delle “Grandi Terme” nella città di Neapolis, ridesta l’attenzione sull’importante insediamento umano rimasto sinora ai margini della storia isolana.
L’intervento mira a salvaguardare una delle poche strutture romane voltate a botte ancora in piedi in Sardegna. Trattasi di una parte dell’ampio complesso termale pubblico della città, che andò sviluppandosi presumibilmente anche a Neapolis tra il II e III secolo d. C.
Il termine “Grandi Terme” fu dato dal prof. Raimondo Zucca nella redazione della sua tesi di laurea per distinguerle dalle “Piccole Terme”, struttura edilizia privata, posto a nord delle “Grandi Terme”.
Attualmente non si conosce l’espansione puntuale del complesso termale che viene stimato all’interno di una spazio compreso tra i 18 metri di larghezza e 15,8 di lunghezza con un’altezza di 3,1 metri, presumibilmente riferito all’altezza del corpo elevato che noi da sempre conosciamo come “Sa cresia de Santa Maria de Nabui”, la chiesa di Santa Maria di Neapolis.

La struttura romana del fabbricato oggetto di restauro ci è data dalla sua costruzione in opus caementicium (agglomerato di calce, sabbia, pietre e mattoni spesso frammentati), tecnica utilizzata nelle grandi opere come il Pantheon, mentre i parametri interno ed esterno sono stati realizzati in opus vittatum mixtum, con tre file di piccoli blocchi calcarei e roccia vulcanica, alternati a due file di laterizi chiamati bessali (bessales) di circa 20 cm per lato.
La chiesa, come detto, è parte integrante del complesso termale di cui si conservano ancora evidenti le tracce dell’apodyterium (il vestibolo principale per l’ingresso e l’uscita dai bagni) il termine greco equivale a “Camera per spogliarsi”. Le trasformazioni avvenute nel tempo ed in particolare dopo l’abbandono dell’uso termale non hanno cancellato le tracce del frigidariun, una ampia vasca rettangolare affiancata da due vasche semicircolari ai lati, utilizzate nell’ultima fase del bagno dopo il passaggio nel tepidarium e calidarium per una sferzata stimolante sulla circolazione sanguigna, necessario inoltre per togliere il sudore sviluppatosi nel transito degli ambienti caldi.

Le “Grandi Terme”, come tutta la città, erano alimentate dal “Castellum acque”, costituito da depositi idrici che ricevevano il prezioso liquido dalle sorgenti di “Laus de biaxi”, attraverso il suo imponente acquedotto lungo cinque chilometri. La sua elevata collocazione sul colle a occidente, ne favoriva la distribuzione per caduta.
Presumibilmente le “Grandi Terme”, come in tutte le terme romane, vennero frequentate da tutti i ceti sociali della città, anche se i ricchi sovente si costruivano le stanze da bagno nelle proprie abitazioni, vedi le “Piccole Terme”. L’uso delle terme nell’impero romano sembrerebbero venir meno, pare per la promiscuità d’uso, considerata da molti scandalosa, tanto che l’imperatore Adriano decretò la separazione dei sessi fra i frequentatori. Le terme erano anche considerate un antidoto del tempo per curare la tubercolosi, rabbia, diarrea e foruncoli, ma erano anche causa di molte malattie date dal contagio di batteri, virus o funghi che proliferavano con la promiscuità e l’uso improprio delle acque non filtrate.

L’abbandono definitivo delle terme nell’impero romano sembrerebbe avvenuto alla sua caduta nel 476 d. C, per gli alti costi di gestione e per le mutate condizioni sociali. In particolare incise sicuramente anche la diffusione del cristianesimo, che contrastò la promiscuità ed il nudismo. In Sardegna la religione cristiana andò espandendosi fin dall’ultimo decennio del II secolo e la presenza cristiana, pur in assenza di scavi sistematici, viene attestata a Neapolis da alcuni frammenti di lucerne del IV d. C. Forse non è un caso che in quel luogo di salubrità, ma per una parte della popolazione anche di scandalo, dopo diverse manomissioni, che interessarono il ricolmo della vasca, l’occlusione e la tamponatura di un finestrone, venne ricavato lo spazio ecclesiale intitolato a Santa Maria. La struttura sembrerebbe essere stata rifinita con un liscio intonaco e decorato a più riprese. Sugli intonaci, ormai in disfacimento, sembrerebbero ancora visibili dei graffiti, alcuni riferibili ad antichi simboli cristiani a testimonianza dell’edifico come luogo di culto. Sul sito in una parte della scheda redatta dalla Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano leggiamo: “I pavimenti in origine dovevano essere di tessere policrome in marmo bianco, ocra, nero e rosso come si è potuto dedurre dai ritrovamenti superficiali effettuati nell’area in passato. Attualmente alcuni lembi pavimentali in posto si possono vedere nel lato sud-est del complesso architettonico, messi in luce dalle ultime campagne di scavo, che hanno evidenziato anche alcune strutture connesse con il frigidadium. In particolare si segnala un lungo muro in opus caementicium e intonacato internamente in asse con altri muri dell’impianto, che sembra chiudere alcuni spazi pertinenti ad altri vani. Al complesso termale, in particolare al suo decoro, si attribuisce una statuetta di Herakles con leontè recante un pomo delle Esperidi nella mano destra”.
Neapolis, oltre l’ecclesiae di Santa Maria, pare ne detenesse una seconda intitolata a Sant’Elena, non è dato sapere se la presenza dei due edifici cristiani in città fosse legata all’ipotesi di alcuni ricercatori che danno Neapolis come prima sede diocesana sino al suo trasferimento nel XI secolo a Terralba.
Sono molti gli interrogativi che ci pone l’insediamento di Neapolis, la speranza è che con questi importanti lavori possano essere riprese le campagne di scavi necessarie per svelarci la storia della città, il ruolo avuto nel sistema storico economico e sociale del territorio e nell’isola di Sardegna.
RIPRODUZIONE RISERVATA