di Roberto Loddi
de Santu ‘Engiu Murriabi
__________________________________

La pianta del cappero “Capparis spinosa”, è un verdisssimo arboscello che cresce naturalmente in tutto il bacino del Mediterraneo da tempi remoti, per via della sua resistenza ai climi caldi e alla capacità di adattarsi in spazi impervi, predilige i terreni aridi e drenati, i muri di pietra secchi, ed è impiegato sia a scopo alimentare che curativo. Del cappero si mangiano i boccioli, “capperi”, mentre i frutti “cucunci” si consumano con minor frequenza. I capperi si raccolgono dal mese di aprile fino a luglio, poi vengono conservati in barili sotto sale, sott’aceto e sott’olio. Il cappero è probabilmente di provenienza tropicale, dell’Asia Minore o Anatolia e dalla Grecia. Proprio dalla Grecia, si hanno fondamentali informazioni documentate dalla cultura letteraria, anche se ancor prima se ne parla nella Bibbia.
Il filosofo Aristotele, una delle menti più brillanti dell’antica Grecia e Dioscoride Pedanio, botanico e medico vissuto nella Roma imperiale ai tempi di Nerone, citano i capperi come ingrediente terapeutico e trattamento di bellezza, mentre Plinio distingue le caratteristiche dei capperi in base alle peculiarità dei terreni, infatti sostiene che i capperi coltivati in Africa provocano infiammazioni alle gengive e invece quelli coltivati in Puglia creano problemi allo stomaco. Il cappero era molto apprezzato come pianta curativa anche da Columella e Galeno e come descrive il medico e botanico Pietro Andrea Mattioli nel XVI secolo, i capperi contribuiscono a lenire i dolori della lombo-sciatalgia, liberare da impurità il torpore della testa, calmare le nevralgie dentali, sanare le ulcere e un tempo si preparavano delle pozioni utilizzate per curare la dilatazione permanente di una vena.
A partire dal I secolo a. C. si conoscono meglio i procedimenti di piantagione e coltivazione della pianta del cappero, si facevano degli scassi nel terreno che venivano riempiti con delle rocce frantumate, questo accorgimento era utile per fare intrecciare le radici delle piante fra loro. In periodo Medievale, i capperi già conciati erano molto richiesti dai mercati dell’Est.
I capperi sono abitualmente utilizzati per insaporite una infinità di piatti, i suoi frutti stuzzicanti sono piacevoli, fragranti, dal gusto intrigante, ideale per gli aperitivi. Grazie alla specificità del terreno, a una moderata ventilazione e all’assenza quasi totale di umidità il cappero, nel gruppo insulare del Mar Tirreno delle isole Eolie e l’Isola di Pantelleria con una produzione annua di oltre il novanta per cento copre il fabbisogno nazionale e prospera da tempo talmente lontano che se ne è persa la memoria. I siciliani sono i più grandi esperti e conoscitori di capperi, a loro vantaggio hanno sicuramente il sole e le condizioni favorevoli alla fruttificazione.
Intorno al 1850, anche in Sardegna e precisamente a Selargius (paese di circa 28.500 abitanti in provincia di Cagliari), si cominciò a coltivare i capperi e grazie ai rigogliosi raccolti, si creò l’occasione per dare lavoro e reddito a tantissime famiglie del posto. Nel periodo di raccolta le donne del paese, andavano nei campi, comperavano i capperi, dopo averli messi in capaci cesti confezionati con i giunchi, crobis mannas, corbas, crobes, corbis, corbeddus, canistus, corbulas, li trasportavano mettendoli sulla la testa, adagiando sopra una sorta di cordone preparato con uno scialle arrotolato per attutire il peso della cesta e a piedi si incamminavano verso le piazze dei mercati ambulanti cagliaritani per venderli o barattarli con altre derrate. I contadini invece li commercializzavano da un paese all’altro in tutta la Sardegna trasportandoli con il carro trainato dai cavalli, dando così l’opportunità a tutti gli isolani di conoscere le peculiarità di questo singolare frutto, dando così l’occasione per poter insaporire tantissimi piatti della tradizione come ad esempio, su conillu a succhittu o a cassolla cun tappara, il coniglio in casseruola con i capperi, ricetta cucinata in tutta l’area del medio Campidano, il cui nome deriva dal succulento intingolo che si forma a fine cottura.
Altrettante ricette famose sono impreziosite con i capperi, come l’antico vitello tonnato alla piemontese, la salsa del Papa, da non dimenticare la salsa verde genovese degna compagna del pesce lesso e il sontuoso “cappon magro”. Tanto per citarne alcune. Vedere un campo di capperi in fiore (bocciolo della pianta), è un’occasione meravigliosa che incanta lo sguardo di chi ha la fortuna di cogliere l’esplosione di colori.
Ingredientis:
1 coniglio ruspante di 1,5 kg tagliato a pezzi regolari, g 60 di guanciale sardo, grandua, battuto a coltello, 2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai di aghi di rosmarino, 4 pomodori secchi ben dissalati, un mazzetto di prezzemolo, 1 carora, 1 cipolla di Zeppara (rigogliosa area della Marmilla), un ciuffo di timo sardo, armidda, vino bianco secco, 3 foglie di lauro, g 60 di capperi di Selargius (tappara o tapparono) ben dissalati, aceto di ottimo vino bianco per la marinata, brodo vegetale, olio extravergine d’oliva, sale e pepe di mulinello q.b.
Approntadura:
priva la carne dalle eventuali parti grasse e le piccole ossicine, poi ponila dentro a una conca di terracotta, scivedda, xivedda, concheddu, con abbondante acqua e aceto in parti uguali e lasciala marinare un’abbondante ora. Passato il tempo, scola i pezzi di coniglio dentro a un capace recipiente insieme al guanciale, un bel giro d’olio e lascialo rosolare fino a quando non avrà preso un bel colore dorato. Fatto, aggiungi l’aglio schiacciato meno uno spicchio, il rosmarino tritato finemente con i pomodori secchi, il prezzemolo, la carota e la cipolla, quindi bagna la preparazione con un bicchiere di vino. Evaporato, unisci le foglie di lauro, i capperi lavati e strizzati, il timo sgranato, una mestolata di brodo bollente e prosegui la cottura dolcemente per tre quarti ‘ora, bagnando la pietanza di tanto in tanto con altro brodo bollente per evitare che il fondo di cottura si asciughi. Prima del termine della cottura, regola il sapore di sale e impreziosiscilo con una generosa macinata di pepe. Servi il coniglio assieme al suo sughetto con fette di pane tipo, coccoi, abbrustolite e strofinate con l’aglio rimasto. Vino consigliato: Carignano rosato del Sulcis, dal sapore armonico e asciutto.
RIPRODUZIONE RISERVATA


















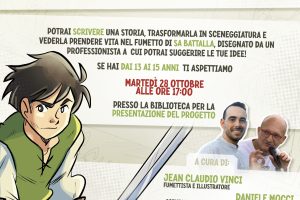






Aggiungi Commento