
Quante volte abbiamo usato questa locuzione latina, intendendo annottare qualche cosa di importante o comunque per far sì che non ci si possa dimenticare. Solo al ricordo dell’olocausto, dei deportati nei campi di concentramento, un brivido attraversa la nostra schiena e il pensiero corre alle centinaia di migliaia di vittime che questo fenomeno ha provocato anche in Sardegna. Il prezzo pagato dalla nostra isola è molto alto, si parla di 12.000 deportati e 250 caduti. Anche Guspini ha avuto i suoi deportati e fra questi Francesco Pinna, classe 1918, deceduto nel 2000 all’età di 82 anni. Ci raccontano la storia le figlie Fernanda e Marina. «Succede sovente che quando vengono a mancare i genitori, noi figli sentiamo il bisogno di approfondire la conoscenza di alcuni momenti della loro vita che per superficialità, per delicatezza nei loro confronti non abbiamo mai pensato o osato chiedere», dice Fernanda Pinna, «tutto prende avvio da due foto di due amici di nostro padre trovate in un cassetto nella casa dei genitori scomparsi. Le foto in questione recano sul retro la dedica e la firma, il luogo e la data: Enrico Pinazzi ed Enore Capelli; Madregolo (Collecchio) Parma; 30 giugno 1943». «Nostro padre», precisa Marina, «ci raccontava spesso che prima dell’otto settembre 1943, si trovava a Larissa in Grecia, con il suo quarto squadrone dei Lanceri di Milano. Per sfuggire al rastrellamento da parte dei tedeschi, con il permesso dei superiori, il 10 settembre riuscì a raggiungere l’Italia con alcuni commilitoni pur tra mille difficoltà. Risalendo la penisola si fermò con questi compagni a Madregolo, piccola frazione del Comune di Collecchio in provincia di Parma, dove trovò ospitalità presso la famiglia Pinazzi, prima che venisse catturato dalle brigate nere a seguito di una spiata e consegnato ai tedeschi che lo deportarono». «Mosse da questo forte desiderio di rivivere dopo tanti anni quello che sicuramente anche il nostro padre avrebbe voluto ritrovare», agginge Fernanda, «con Marina decidemmo di iniziare la nostra ricerca. Decine e decine di telefonate a Collecchio e a Parma ai vari Pinazzi e Capelli, con risultati deludenti. Questa ricerca durò alcuni mesi ma proprio mentre, scoraggiate stavamo per smettere di cercare, riuscimmo a contattare Anna Pinazzi, sorella di Enrico, uno dei due amici di nostro padre, che ricordava molto bene il nostro genitore come una persona educata, gentile e rispettoso delle donne del posto». «Alcuni anni dopo questo ritrovamento», sottolinea con emozione Fernanda, «abbiamo deciso di incontrare queste persone e visitare i luoghi dove nostro padre aveva lavorato come contadino prima di essere deportato. L’incontro con queste persone e con tante altre che avevano avuto modo di conoscere nostro padre e gli attestati di stima che ci hanno riservato, resteranno scolpiti nei nostri cuori».

Una storia certamente molto commovente quella finora raccontata dalle sorelle Pinna ma ancora più toccante è quanto rileviamo dal foglio matricolare di Francesco Pinna che riportiamo fedelmente”nel gennaio 1944 fu internato nel campo di concentramento di KaiserStembruck e dopo 15 giorni trasferito al campo di concentramento di Stenten (Germania) e impiwgato in lavori di manovalanza. Il 13 aprile 1945 fu liberato dalle truppe americane. Passò il confine del Brennero il 16. Il 27 maggio si imbarcava da Civitavecchia sul piroscafo mercantile “Langano”, sfuggendo al controllo del personale di bordo e il giorno 29 sbarcò a Cagliari. Francesco Pinna ha vissuto la triste esperienza della deportazione ma ancora tante di queste storie devono essere scoperte e raccontate affinché non si debba mai dimenticare l’orrore provocato dal nazifascismo. Il soggiorno a Stenten ha certamente lasciato delle ferite insanabili in chi l’ha vissuto. Quello Stalag (campo di concentramento per sottufficiali e truppa) XVII A (il numero distintivo del campo) era uno dei 40 campi satellite di Mauthausen dove vennero deportati complessivamente 84.000 prigionieri. Di questi 65000 furono impiegati come lavoratori forzati, da imprese per la costruzione degli impianti produttivi e fabbriche, al riparo delle incursioni aeree. La costruzione di queste gallerie fu effettuata senza riguardo alcuno per la salute e la vita dei prigionieri, causando molte vittime. Questa importante testimonianza contribuirà certamente a farci sentire più vicino il dramma dell’olocausto, della prigionia nei campi di concentramento generata dalla follia e dalle mire espansionistiche di alcuni personaggi che speriamo appartengano alla storia passata e auspichiamo non abbiamo mai più a ripetersi, per questo è fondamentale non dimenticare.
Maurizio Onidi
RIPRODUZIONE RISERVATA





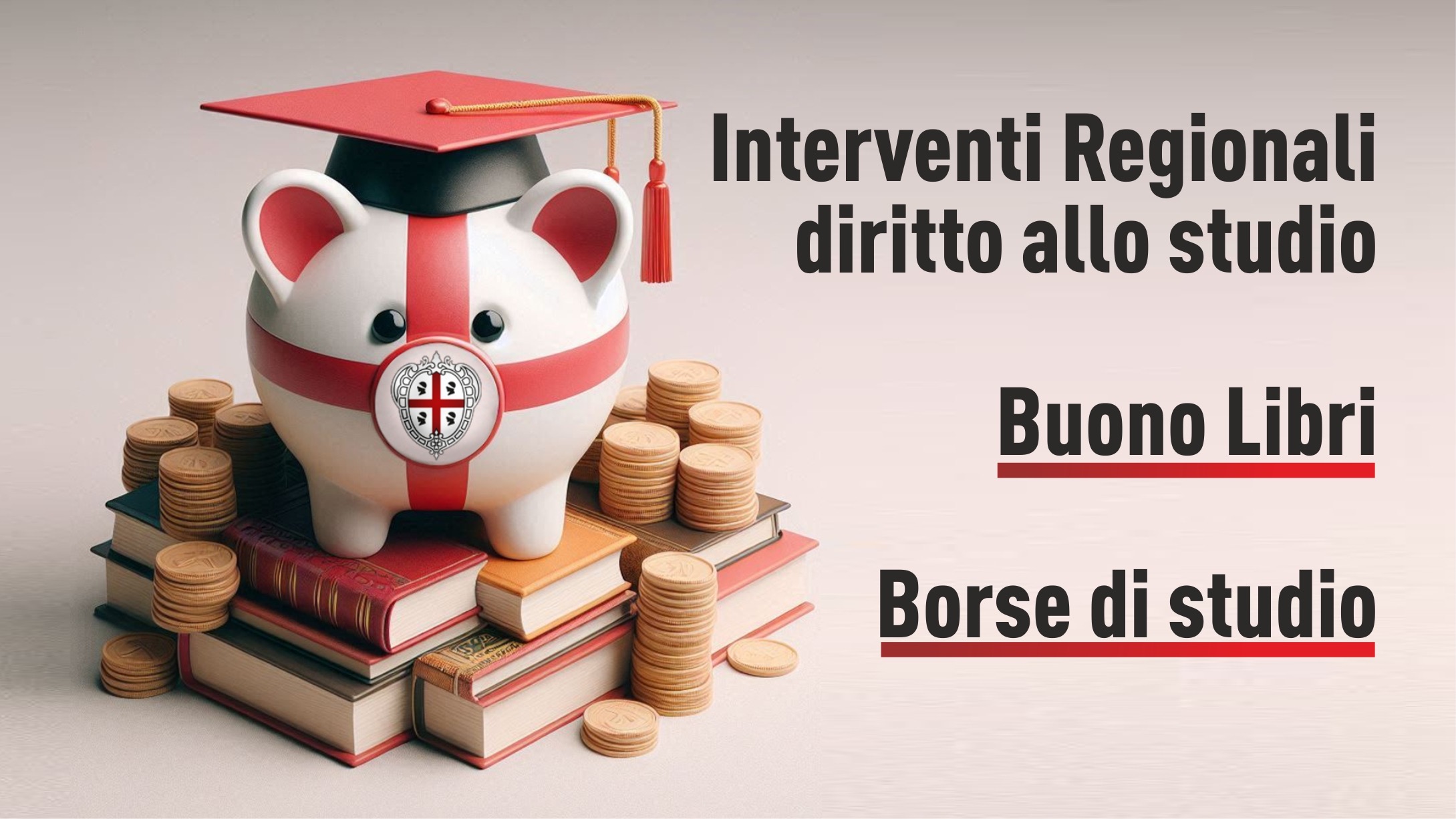





















Aggiungi Commento