
E castanza e nuche e nuchedda, turrasa e tallerisi e pabia de forru, pisceddas de casu, discoso po pesare caso, acconcia cossu e acconcia paracquas – castagne, noci e nocciole, mestoli, taglieri e pale da forno, forme di formaggio, scodelle per il latte e per dare la forma al formaggio, riparo busti – farsetti (corpetti di pelle – cosso‘e peddhe) e ombrelli. Questa era la sequenza di parole che pronunciavano in cantilena i commercianti, percorrendo le vie dei paesi del Campidano per vendere la loro merce, provenienti da Aritzo – cab’e susu – capo di sopra, con le sporte cariche sulla groppa del proprio cavallo. Infatti come si legge sul vocabolario sardo logudorese – italiano di Pietro Casu, illustre predicatore e poeta, i – castanzajus – venditori ambulanti di castagne, anticamente venivano in Medio Campidano a cavallo dalla Barbagia, dopo giorni e giorni di viaggio. Le povere bestie erano magre e dimostravano le fatiche e le privazioni del lungo cammino e si riposavano solo dopo avere venduto il carico sopportato durante il percorso sostenuto. Si presume però che per trasportare tutta la merce utilizzassero un carro attrezzato, con almeno un cavallo di scorta. Ho ancora vivo il ricordo del sapore di quelle castagne, avevano un sapore indimenticabile, soprattutto quando mia mamma faceva le caldarroste – castanza – castàngia – arrostìa -. Dopo averle cotte le metteva in un cestino – crobi – con dei canovacci per tenerle al caldo, così si potevano sbucciare bene e le poneva al centro del tavolo. poi sistemava il braciere sotto al tavolo con la brace, io con i mie fratelli ci sedavamo tutt’intorno ponendo i piedi sopra alla sagoma di legno del braciere, per tenerli al caldo mentre mangiavamo le castagne arrostite con pochissimo vino – piriciòu – piriciòlu – binetu -. Si trattava di un vinello beverino o mescola (nell’antica Roma lo chiamavano Circumcisicium) che i contadini bevevano tutti i giorni nei mesi molto freddi ed era ottenuto dalla rifermentazione delle vinacce con abbondante rabbocco d’acqua di fonte, con l’aggiunta di zucchero e altro mosto appena torchiato. Che bei tempi! Ricordo anche quando Mamma Albina con le castagne ci preparava il risotto, cucinato con il guanciale – grandua e il – martutzu – crescione: – arrosu cun castàngia de aritzu e martutzu aresti -.
Il crescione “Nasturzio – Nasturtium officinale” fa parte della famiglia delle Crocifere e in dialetto sardo si pronuncia – martutzu – matutzu, matuzzu – martuthu -. Il crescione è una pianta aromatica officinale conosciuta fin dall’antichità, dal sapore pungente che ricorda quello delle foglie del ravanello. La pianta cresce nelle campagne, predilige i fossati, le core d’acqua, gli acquitrini e i fiumiciattoli con le acque trasparenti. Il crescione ha proprietà nutrizionali, fa bene all’organismo, ha la peculiarità di depurarlo ed è ricco di virtù afrodisiache. In gastronomia insaporisce risotti, minestre, zuppe, insalate ed è delizioso consumato in purezza, condito con olio extravergine d’oliva e sale. Come è arcaica la conoscenza del crescione, così è quella delle castagne, che erano già utilizzate nell’antichità. Infatti erano già note ai greci e ai romani, anche se soltanto nel Medioevo si hanno le prime testimonianze che certificano l’interesse sulla piantagione dei castagneti. Tanto è vero che, nell’undicesimo secolo, risulta da atti notarili che la contessa Matilde di Canossa, potente feudataria, indica la disposizione geometrica delle piante proponendo il giusto spazio di coltura tra una pianta e l’altra. Nel tredicesimo secolo le castagne, vengono menzionate nei censimenti doganali di Firenze. Ma il primo a parlare della castagna (Castanea Sativa) in Europa, fu Senofonte nel sesto secolo, che definì il castagno come “albero del pane”. In effetti i suoi frutti hanno per secoli rappresentato una delle principali fonti di sostentamento per le famiglie. Ogni anno ad Aritzo, le associazioni competenti organizzano un appuntamento dedicato alle castagne, con escursioni, mostre e degustazioni gratuite di caldarroste con vino novello a volontà.
Ingredientis:
g 320 di riso carnaroli di Sardegna, g 250 di castagne, 2 cipollotti, g 120 di guanciale sardo ridotto a poltiglia, g 60 di pecorino fiore sardo grattugiato, brodo vegetale, 4 rametti di rosmarino, vino bianco secco, un mazzo di crescione freschissimo, olio extravergine d’oliva, sale e pepe di mulinello q.b.
Approntadura:
prima di tutto, poni a lessare le castagne fresche incise in una pentola contenente acqua leggermente salata e falle cuocere per mezz’ora. Trascorso il tempo occorso, lasciale intiepidire, poi spellale, riducile a tocchetti (lasciane 4 intere per la guarnizione dei piatti) e metti il ricavato dentro a una ciotola. Fatto, trita i cipollotti e falli rosolare in un tegame insieme a un giro d’olio, il battuto di guanciale -grandua – e una spruzzata di vino. Evaporato, unisci il riso e lascialo sfrigolare due minuti, quindi bagnalo con una mestolata di brodo bollente, dopodiché aggiungi le castagne tenute da parte, un’altra mestolata di brodo bollente e continua la cottura per diciotto minuti, aggiungendo sempre brodo per mantenerlo all’onda. Un minuto al termine, incorpora il crescione – martutzu – ben lavato e spezzettato, il formaggio, subito dopo regola il sapore di sale, impreziosiscilo con una generosa macinata di pepe e fallo mantecare, prima di servirlo in piatti individuali, decorati ognuno con un rametto di rosmarino e una castagna. Vino consigliato: Mandrolisai rosso, dal sapore asciutto sapido con retrogusto amarognolo, armonico e tipico.
RIPRODUZIONE RISERVATA




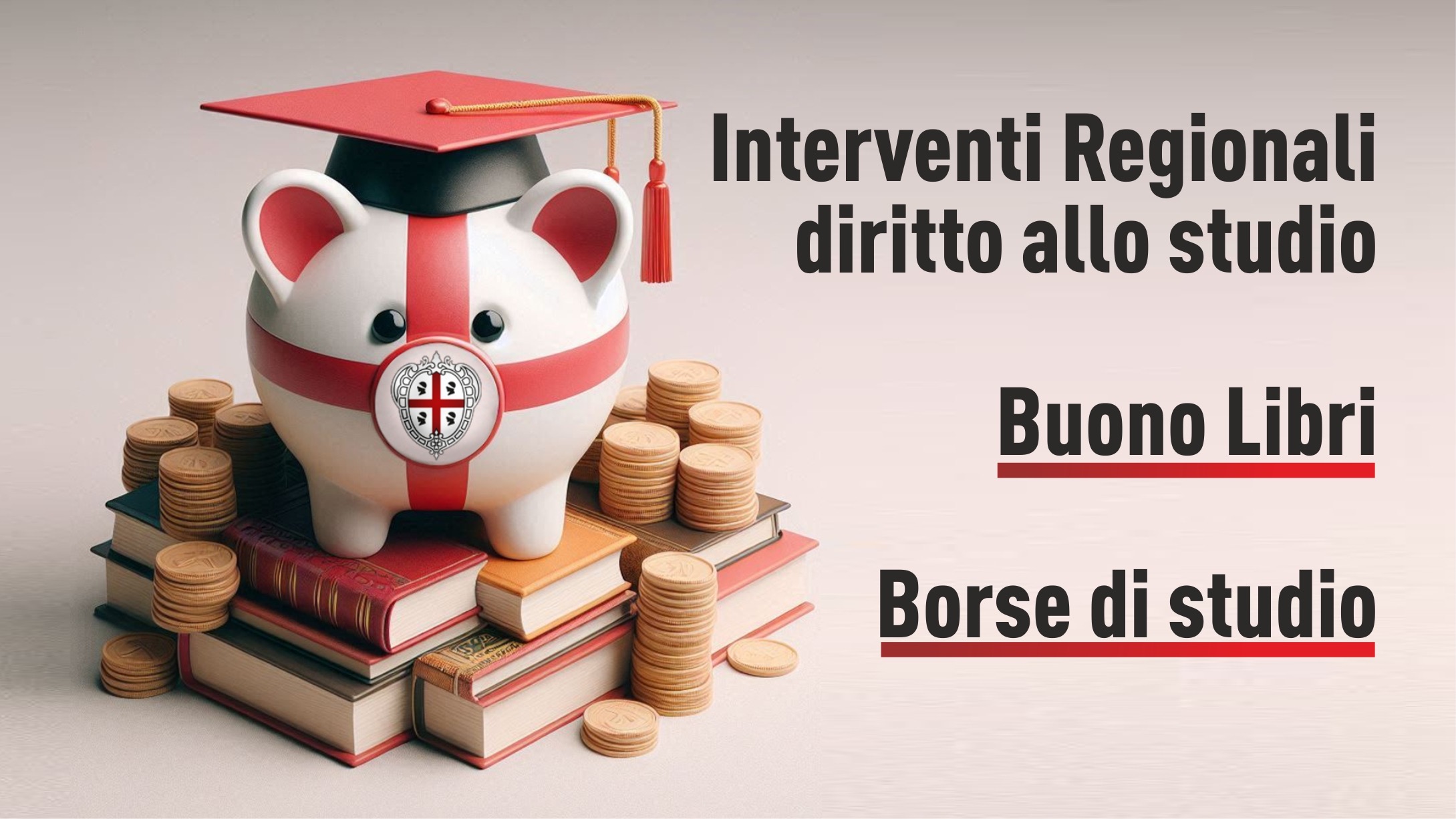






















Aggiungi Commento