di Antonio Obinu
 Le prime notizie certe riferite alla Cattedrale di Cagliari risalgono al periodo 1254÷1258 allorché, concluso vittoriosamente il conflitto con Genova, la comunità pisana in città decise la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria di Castello che divenne la nuova cattedrale trasferendola dall’antica sede di Santa Igia, o più correttamente Santa Illa contrazione di Santa Cecilia. Alla pianta originale venne aggiunto un braccio trasversale dandogli la forma a croce latina che ha attualmente.
Le prime notizie certe riferite alla Cattedrale di Cagliari risalgono al periodo 1254÷1258 allorché, concluso vittoriosamente il conflitto con Genova, la comunità pisana in città decise la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria di Castello che divenne la nuova cattedrale trasferendola dall’antica sede di Santa Igia, o più correttamente Santa Illa contrazione di Santa Cecilia. Alla pianta originale venne aggiunto un braccio trasversale dandogli la forma a croce latina che ha attualmente.
Quando nel 1326 gli aragonesi sconfissero i pisani, vollero immediatamente dare la propria impronta anche nell’architettura della città. Venne completato il braccio destro del transetto e la Cattedrale fu scelta come il luogo in cui gli stamenti (i bracci del parlamento sardo) si riunivano in seduta plenaria davanti al viceré. Questo passaggio di stile, dal romanico dei pisani al gotico degli aragonesi, è particolarmente evidente nei prospetti laterali del transetto e nei rispettivi portali giunti intatti ai nostri giorni. Mentre il portale Nord a sinistra della Cattedrale è in stile evidentemente romanico, quello a destra è finemente lavorato e più ricco di decorazioni, sormontato da tre archi gotici trilobati.
 All’inizio del 1600 l’arcivescovo di Cagliari Francisco d’Esquivel decise di realizzare nell’area sottostante il presbiterio e il coro della Cattedrale una chiesa sotterranea allo scopo di dare un’unica sepoltura ai martiri cittadini. Scavata quasi interamente nella roccia, vennero realizzate tre cappelle: una centrale o della Madonna dei Martiri e due laterali dedicate ai santi Lucifero e Saturnino, quest’ultimo patrono di Cagliari. Si contano 179 nicchie ognuna delle quali riporta su di una lapide marmorea il nome del defunto.
All’inizio del 1600 l’arcivescovo di Cagliari Francisco d’Esquivel decise di realizzare nell’area sottostante il presbiterio e il coro della Cattedrale una chiesa sotterranea allo scopo di dare un’unica sepoltura ai martiri cittadini. Scavata quasi interamente nella roccia, vennero realizzate tre cappelle: una centrale o della Madonna dei Martiri e due laterali dedicate ai santi Lucifero e Saturnino, quest’ultimo patrono di Cagliari. Si contano 179 nicchie ognuna delle quali riporta su di una lapide marmorea il nome del defunto.
La struttura subì un altro importante intervento nella seconda metà del 1600 quando venne disposta la demolizione della navata centrale per ricostruirla e allargarla. Per rinforzare la struttura vennero sacrificate le cappelle trecentesche di costruzione pisana che vennero murate per rinforzare i muri perimetrali allo scopo di sopportare il peso delle volte, non più in legno, e della cupola. I lavori di manutenzione sono continuati sino alla fine del secolo scorso e gli interventi sono stati finalizzati soprattutto al rinforzo dell’equilibrio dell’intera struttura e al recupero delle due cappelle trecentesche a destra e sinistra del presbiterio.
 l termine dei lavori la chiesa risulta lunga 39 metri con il transetto di 36,25 metri; l’altezza al vertice della cupola 36 metri; la superficie totale circa 1000 metri quadrati. Ulteriori ampliamenti non furono più possibili perché limitata dai palazzi attigui e dallo strapiombo della rocca su cui sorge.
l termine dei lavori la chiesa risulta lunga 39 metri con il transetto di 36,25 metri; l’altezza al vertice della cupola 36 metri; la superficie totale circa 1000 metri quadrati. Ulteriori ampliamenti non furono più possibili perché limitata dai palazzi attigui e dallo strapiombo della rocca su cui sorge.
Anche la facciata ha subito diverse modifiche. Così come la vediamo oggi è stata realizzata nel 1930 quando si è cercato di imitare lo stile pisano originario. Allo scopo è stata utilizzata la pietra calcarea del colle di Bonaria. Il campanile conserva la sua linea originale: è caratterizzato da 4 campane la più grande delle quali venne rifusa nel 1822 misura 1,5 metri di altezza, 1,5 di diametro e 4,70 metri di circonferenza.
 Sulla facciata oltre alle porte del transetto già menzionate, si aprono i tre portali centrali tutti sovrastati da una lunetta dove con la tecnica del mosaico sono rappresentati rispettivamente la Madonna con Bambino in quello mediano, Santa Cecilia patrona della Cattedrale in quello destro e San Saturnino nel portale sinistro.
Sulla facciata oltre alle porte del transetto già menzionate, si aprono i tre portali centrali tutti sovrastati da una lunetta dove con la tecnica del mosaico sono rappresentati rispettivamente la Madonna con Bambino in quello mediano, Santa Cecilia patrona della Cattedrale in quello destro e San Saturnino nel portale sinistro.
L’interno si compone di tre navate con sei cappelle laterali. Ai lati del portone centrale sono posizionati due amboni (tribuna in marmo per le letture) realizzati nella seconda metà del 1100 dal Maestro Guglielmo per il Duomo di Pisa, donato poi alla città di Cagliari nel 1312. Originariamente alla base si trovavano i quattro leoni in marmo che vennero in seguito utilizzati per ornare il presbiterio (nel 1670 circa). L’ambone venne diviso in due parti e posizionate dove attualmente si trova, i leoni sostituiti con quattro “dadi marmorei” che sorreggono le colonne originali. Nella navata di destra si affacciano nell’ordine la cappella di Santa Cecilia e la cappella della Madonna di Sant’Eusebio nativo di Cagliari e vescovo di Vercelli. È chiamata anche la cappella della Madonna Nera in riferimento a quanto vuole la tradizione secondo la quale ritornando dal suo esilio in Palestina il Santo fece dono di tre statue nere della Madonna, una delle quali alla sua città natale. La terza cappella è quella di San Michele, dai più considerata la più importante della Cattedrale da un punto di vista artistico: quattro colonne di marmo a spira fanno da cornice alla scena centrale, San Michele e gli angeli che scacciano i demoni. L’opera del 1700 è realizzata in marmo bianco da uno scultore genovese, riprende in maniera quasi ottimale lo stile di Gian Lorenzo Bernini.
 Giunti nel transetto altre due cappelle meritano la nostra attenzione: la prima dedicata a Sant’Isidoro edificata nel 1683 e la seconda, a destra della porta d’accesso alla Sacrestia, chiamata della “Sacra Spina” perché destinata ad accogliere una delle Sacre Spine della corona del Cristo. Trafugata dalla Santa Sede a seguito del sacco di Roma del 1527, la nave che doveva portarla in Spagna fu costretta da una burrasca a trovare riparo in città. Per mantenere fede alla promessa fatta nel caso si fossero salvati, il comandante della nave fa omaggio della sacra reliquia all’Arcivescovo di Cagliari Girolamo di Villanova. In modo del tutto simile giunse il Trittico di Clemente VII rubato dalle stanze papali durante l’assedio e il saccheggio dei Lanzichenecchi alla città di Roma tra il mese di Maggio ed Ottobre del 1527. Si tratta di tre pannelli in legno di Rovere dipinti ad olio della prima metà del 1400 della lunghetta totale di 1,4 metri. Il dipinto centrale è sicuramente attribuibile al pittore fiammingo Rogier wan de Weyden, vi è rappresentata la Madonna Addolorata e il Cristo con la corona di spine; nei pannelli laterali, probabilmente realizzati dagli allievi del maestro belga, viene raffigurata Santa Margherita con il drago a destra, la Madonna con il Bambino e Sant’Anna in quello a sinistra. L’opera, anch’essa diretta in Spagna, arrivò a Cagliari perché le condizioni del mare non permettevano una navigazione sicura. Pentito del gesto l’autore del furto un avventuriero spagnolo di nome Juan Borsena, si confidò con un frate francescano compagno di viaggio che lo convinse a restituire l’opera all’Arcivescovo della città di approdo. Monsignor Villanova comunicò immediatamente a Papa Clemente VII il ritrovamento di entrambe e come segno di riconoscimento il Papa ne fece dono alla città di Cagliari con Breve Papale del 23 Luglio 1531.
Giunti nel transetto altre due cappelle meritano la nostra attenzione: la prima dedicata a Sant’Isidoro edificata nel 1683 e la seconda, a destra della porta d’accesso alla Sacrestia, chiamata della “Sacra Spina” perché destinata ad accogliere una delle Sacre Spine della corona del Cristo. Trafugata dalla Santa Sede a seguito del sacco di Roma del 1527, la nave che doveva portarla in Spagna fu costretta da una burrasca a trovare riparo in città. Per mantenere fede alla promessa fatta nel caso si fossero salvati, il comandante della nave fa omaggio della sacra reliquia all’Arcivescovo di Cagliari Girolamo di Villanova. In modo del tutto simile giunse il Trittico di Clemente VII rubato dalle stanze papali durante l’assedio e il saccheggio dei Lanzichenecchi alla città di Roma tra il mese di Maggio ed Ottobre del 1527. Si tratta di tre pannelli in legno di Rovere dipinti ad olio della prima metà del 1400 della lunghetta totale di 1,4 metri. Il dipinto centrale è sicuramente attribuibile al pittore fiammingo Rogier wan de Weyden, vi è rappresentata la Madonna Addolorata e il Cristo con la corona di spine; nei pannelli laterali, probabilmente realizzati dagli allievi del maestro belga, viene raffigurata Santa Margherita con il drago a destra, la Madonna con il Bambino e Sant’Anna in quello a sinistra. L’opera, anch’essa diretta in Spagna, arrivò a Cagliari perché le condizioni del mare non permettevano una navigazione sicura. Pentito del gesto l’autore del furto un avventuriero spagnolo di nome Juan Borsena, si confidò con un frate francescano compagno di viaggio che lo convinse a restituire l’opera all’Arcivescovo della città di approdo. Monsignor Villanova comunicò immediatamente a Papa Clemente VII il ritrovamento di entrambe e come segno di riconoscimento il Papa ne fece dono alla città di Cagliari con Breve Papale del 23 Luglio 1531.
 Altri elementi di notevole interesse sono la grande lampada d’argento alta 1,47 m opera di una argentiere cagliaritano del 1602, l’altare maggiore: sovrasta il Santuario dei Martiri ed ingloba l’originale altare della chiesa di Santa Maria di Castello. Nel braccio sinistro del transetto abbiamo la cappella del crocifisso del 1787 e la cappella pisana o del Sacro Cuore, risalente al periodo del primitivo ampliamento del XIII secolo, quindi il Monumento a Martino d’Aragona il Giovane, morto nel 1409 durante la conquista della Sardegna, fu inaugurato solamente nel 1680 quasi tre secoli dopo la sua morte.
Altri elementi di notevole interesse sono la grande lampada d’argento alta 1,47 m opera di una argentiere cagliaritano del 1602, l’altare maggiore: sovrasta il Santuario dei Martiri ed ingloba l’originale altare della chiesa di Santa Maria di Castello. Nel braccio sinistro del transetto abbiamo la cappella del crocifisso del 1787 e la cappella pisana o del Sacro Cuore, risalente al periodo del primitivo ampliamento del XIII secolo, quindi il Monumento a Martino d’Aragona il Giovane, morto nel 1409 durante la conquista della Sardegna, fu inaugurato solamente nel 1680 quasi tre secoli dopo la sua morte.
Nella navata di sinistra si aprono invece la cappella del Battistero, la cappella di Santa Barbara, testimonianza del dominio piemontese in Sardegna è caratterizzata per i marmi e per il dipinto che rappresenta la santa. Infine, la cappella della SS.MA Vergine della Mercede, testimonianza della presenza spagnola nell’isola.
A conclusione non resta che parlare dei dipinti della volta della navata e del transetto, opera cagliaritano Filippo Figari, nonché della vele della cupola dove sono rappresentati i quattro evangelisti e la volta del coro, dipinto nel 1841 da un altro illustre eccellente pittore sardo Antonio Caboni.
La visita della Cattedrale è sempre consentita ad eccezione dei momenti in cui si svolgono le funzioni.
RIPRODUZIONE RISERVATA

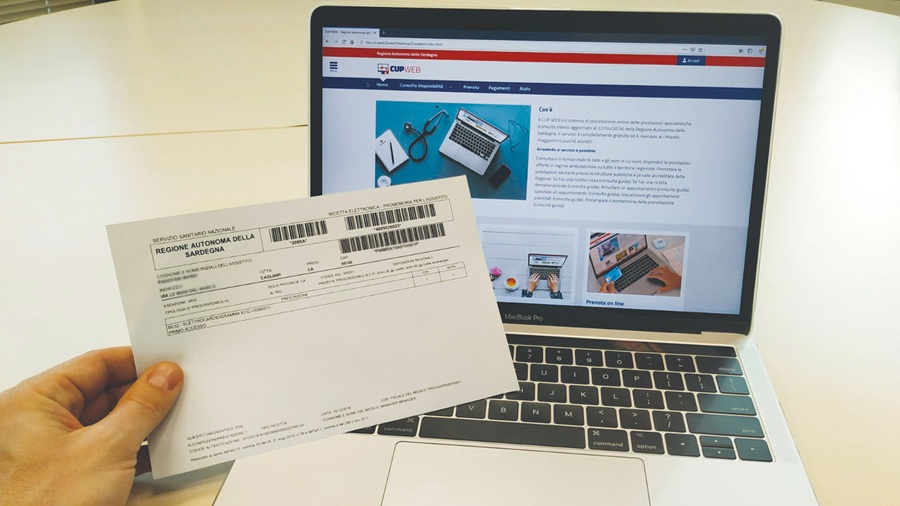

























Aggiungi Commento